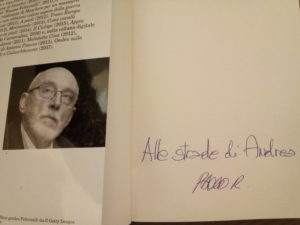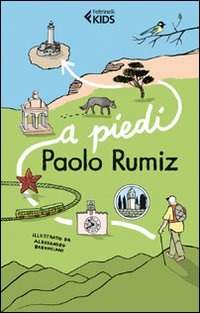La scorsa estate ho passato molto tempo sull’appennino pistoiese. Ho raccontato quasi tutto. Ma qualcosa mi era sfuggito. Forse perché è stato un periodo terribile che cerco di “rimuovere” o forse chissà per quale altro motivo. Recentemente ho ritrovato gli appunti del 30 giugno… ed è un posto che vale la pena conoscere.
Raccontare la mezza giornata a Campo Tizzoro non è facile, è da tempo che cerco di trovare il modo giusto per farlo. E’ un posto strano, affascinante (di un fascino tutto particolare) e anche un pochino inquietante. A prima vista può sembrare una fabbrica a forma di paese oppure, viceversa, un paese a immagine e somiglianza della fabbrica. In realtà è un museo di “antropologia industriale” a cielo aperto.
Arrivando non possono sfuggire queste grandi ogive di cemento, ce ne sono 8 (mi pare) in tutto. E subito pensi che siano un monumento alla stupidità guerrafondaia del ‘900. Poi ti spiegano che sono pozzi di accesso al labirinto sotterraneo delle gallerie anti-aeree. Un vero e proprio “paese ipogeo” che si dirama parecchi metri sotto al paese reale.

La storia di Campo Tizzoro si sviluppa in simbiosi con quella della SMI (Società Metallurgica Italiana). Ed è la storia di un’epoca lontana, quando la fabbrica era ancora radicata in un tessuto sociale, quando l’Economia dipendeva dalla Comunità e non viceversa. Forse sto anche esagerando però mai come il documentario, oserei dire esilarante, dell’Istituto Luce che inizia la visita all’ex stabilimento. Serve una sana (e coraggiosa) curiosità antropologica per affrontare il video. E allora, forte della tua curiosità, puoi scoprire tutte le “opere assistenziali” della SMI: le scuole, gli alloggi per operai e dirigenti, gli spazi ricreativi… addirittura i luoghi di culto. Scopri che “ampi e moderni fabbricati forniscono ai lavoratori le sane gioie di un comodo focolare”. E risalendo nella gerarchia aziendale sono riservate delle “villette civettuole per i dirigenti”.

Mentre i papà sono al lavoro “piccoli alunni lindi disciplinati e volenterosi vanno allo studio come a una festa”. E qui, a scuola, “le bimbette, che evidentemente ricevono un ottimo esempio in casa, promettono di diventare brave massaie” (lo giuro, dice veramente così). Ognuno ha il suo posto nel quartiere residenziale della SMI e agli scapoli sono riservati i posti in albergo dove possono rifocillarsi al ristorante. Ma la voce narrante ci tiene a precisare che “nulla può eguagliare la poesia del desco familiare dove siede la prolifica famiglia operaia”. E alla fine la voce fuori campo aggiunge un laconico commento: “Poveri scapoli!”.
Ad un certo punto, mentre guardi il documentario, ti aspetti che salti fuori Corrado Guzzanti che, alla guida di un manipolo di arditi, si lancia alla conquista di Marte per “spezzare le reni” ai rossi marziani bolscevichi. In fondo c’è qualcosa di ridicolosamente educativo in questi documentari LUCE. E’ impossibile trattenere la risata, ma è altrettanto utile a capire cosa siamo stati e come, nel corso di pochi decenni, può cambiare la cultura di un popolo.
Della fabbrica di munizioni della SMI non ho molto da mostrare. Le foto sono vietate per motivi di “riservatezza” visto che è pieno di munizioni di ogni taglia. Si va dai bossoli calibro 305 per cannoni Skoda delle navi austro-ungariche fino ai pallettoni da caccia. Un piccolo angolo su un tavolino defilato è dedicato al caso JFK: già perché i bossoli trovati a Dallas avevano il marchio “SMI Campo Tizzoro” e, per questo motivo, la fabbrica fu sottoposta all’inchiesta del governo americano.

Ma la cosa più interessante, sebbene un po’ angosciante, sono le gallerie sotterranee. Alcuni chilometri di tunnel, tra i 20 e 30 metri di profondità, costruiti, a partire dal 1937, per difendere tutti gli abitanti dai possibili attacchi aerei. In una calda giornata d’estate si apprezza il refrigerio di questi ambienti: non più di 10 gradi. Però camminando per questi lunghissimi corridoi non si può evitare di percepire l’angoscia della quale sembrano trasudare queste pareti. E ti puoi solo vagamente immaginare la sensazione che, durante un’evacuazione, si doveva provare qui dentro. Tutti stipati come animali ma rassicurati dal fatto che “la disciplina è la miglior garanzia di salvezza”. E la disciplina la ritrovi nelle ferree indicazioni come quella che ci ricorda che “è assolutamente vietato sputare”. Cose di altri tempi, ma non così lontani.